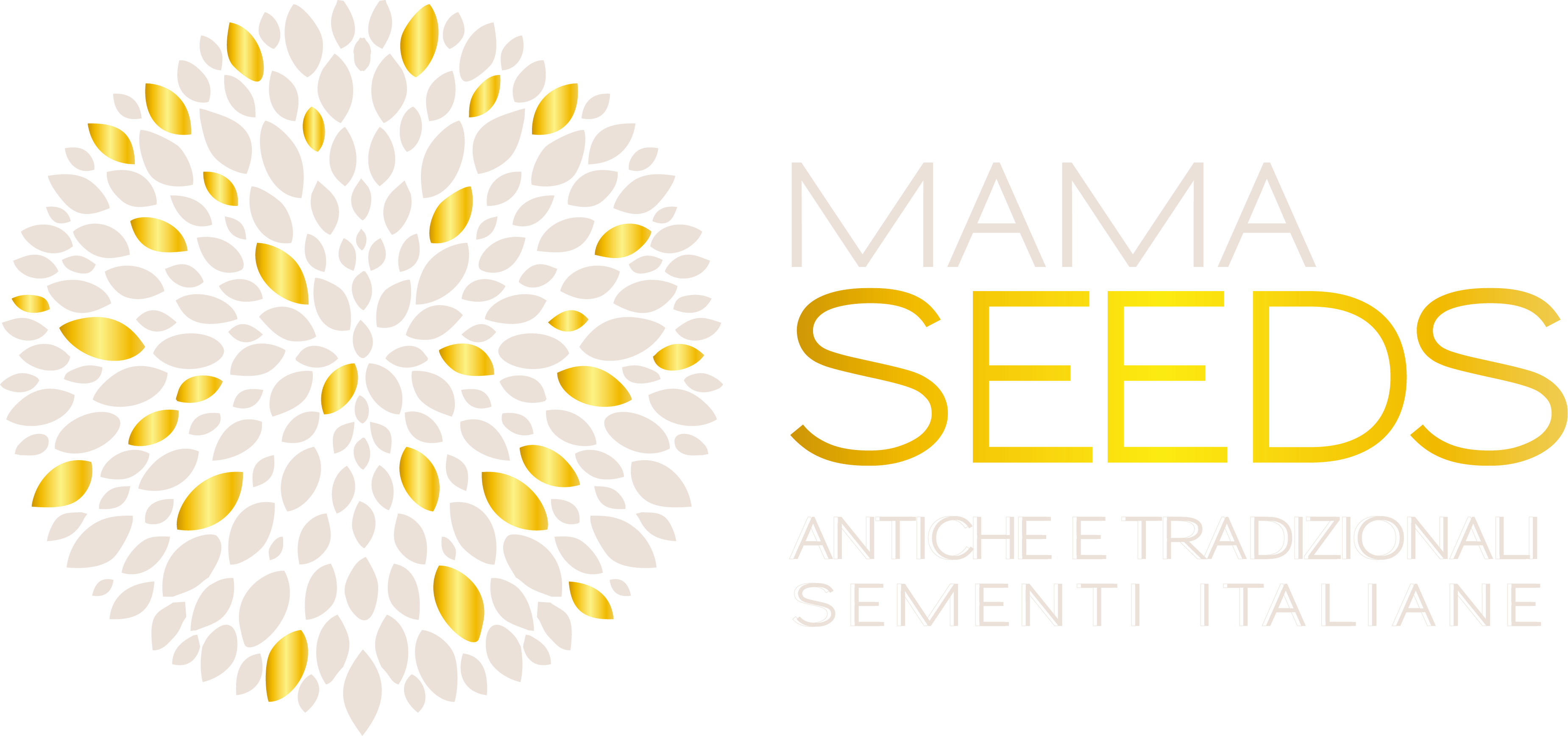Di Alessia Montani e Fabrizio Luciani
1. Conoscenza, memoria e tradizioni culturali
Il nostro Paese ha un ineguagliabile patrimonio paesaggistico, storico, archeologico, artistico; in questo DNA culturale dovrebbero rientrare, a pieno titolo, le qualità irripetibili dei prodotti naturali che su questi territori nascono e maturano e che sono alla base di solidissime tradizioni agricole ed alimentari selezionate attraverso processi evolutivi secolari. Non a caso l’Italia era la meta preferita degli europei che, durante lunghi grand tours, perfezionavano le loro conoscenze politiche, artistiche, culturali e scoprivano, seppure tra mille contraddizioni, una diversa qualità della vita, più morbida, solare e basata su materie prime e capacità gastronomiche irripetibili.
In questa comune integrazione di paesaggio, memoria storica, cultura artistica e tradizioni agroalimentari, il nostro Paese riconosce la sua identità nazionale e partendo da questa comune e stabile percezione di sé, declinata al passato ed orientata al futuro, la stessa comunità nazionale può avvicinarne altre: in rapporti talora organizzati come semplice e mutuo confronto; altre volte come scambi economici nei quali una frazione di quell’identità culturale è una fonte di investimento economico, potenzialmente idoneo a rendimenti utili alla conservazione di quello stesso patrimonio culturale, attraverso ulteriori investimenti, nonché attraverso sempre nuove e molteplici prospettive di lavoro.
La conoscenza è coscienza del nostro passato. La memoria però non è solo attitudine psichica dell’individuo a ricordare e a conservare dati, immagini, parole. È fondamentale anche per grandi gruppi di individui, che vogliano guardare ottimisticamente al futuro, i quali solo attraverso la memoria di una comune identità culturale e simbolica, che attraversa il tempo ed appartiene a tutti, possono stabilizzarsi in comunità politiche organizzate.
Per queste comunità, la memoria di una cultura condivisa costituisce il primo dei beni comuni, anzi la precondizione alla loro possibilità di riconoscere altri fattori naturali e culturali come beni comuni, indivisibilmente appartenenti ad una società politica consapevole di sè stessa.

2. Le antiche sementi e la tradizione italiana
Tutto il nostro passato è con noi, e per vederlo non dovremmo far altro che voltarci, suggeriva Henri Bergson. Tra le materie prime di antica ascendenza agroalimentare – che ancora sono con noi, ci appartengono e delle quali occorre conservare la memoria consegnandola intatta alle future generazioni – ci sono le sementi di antiche varietà vegetali originarie del nostro Paese, come il grano, le brassicacee, gli ortaggi, la frutta, i vitigni, le erbe officinali, che vengono ancora coltivate, in quanto sono state conservate da contadini e agricoltori cd. custodi, che le hanno tramandate di generazione in generazione, mantenendole nella loro purezza originaria. Questi antichi semi rilevano quindi, da un lato, come segmento di un patrimonio di inestimabile valore, attualmente abbandonato; e, d’altro, come potenzialità economica, potendo costituire un interessante volano economico, come Made in Italy dei semi, alla base della trasformazione agroalimentare di una nuova filiera. Ma non solo, i semi antichi e le nostre antiche culture possono rappresentare un volano economico anche per il settore del turismo, ormai sempre più esperenziale, rivolto alla scoperta dei territori e delle loro ricchezze non solo monumentali.
Attualmente, invece, la biodiversità agricola è lasciata alla cura esclusiva di volenterosi agricoltori custodi, di imprese c.d. eroiche e centri di ricerca, il cui generoso impegno risulta però del tutto insufficiente a causa di una scarsa consapevolezza collettiva diffusa sull’importanza di quel patrimonio e dell’assenza di un’identità giuridica, che di quel patrimonio consentano un’adeguata tutela. Ed infatti, nel nostro ordinamento sono ricompresi nel Patrimonio culturale nazionale, che è il più ricco al mondo, anche i beni ambientali, le aree con caratteri di singolarità e valore paesaggistico, geologico, naturalistico, come parchi e riserve, panorami e punti di vista panoramici, territori costieri, circostanti ai laghi, fiumi e corsi d’acqua, cime montuose, vulcani, ghiacciai, boschi e foreste, ma non sono menzionati in questo patrimonio i nostri antichi, tradizionali semi endemici, pur essendo la biodiversità italiana la più ricca d’ Europa.
È di tutta evidenza quindi che occorre, anzitutto, creare una una identità giuridica e donare una paternità alla biodiversità agricola e
costituire poi una filiera agroalimentare delle antiche sementi italiane, in modo da non disperdere queste risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico, ripristinando gli equilibri dell’ecosistema a favore dell’ambiente, ma anche migliorando la salute e il benessere dell’uomo. Sono ormai numerose, infatti, le evidenze medico-scientifiche, che dimostrano la stretta correlazione tra alcune malattie estremamente diffuse negli ultimi ‘50 anni (celiachia, gluten sensitivity, diabete, obesità, infiammazioni, etc.) e l’introduzione di semi non italiani o geneticamente modificati e l’utilizzo di prodotti da esse derivati come la farina, il pane, la pasta, la pizza, etc. Si tratta di un’operazione di salvaguardia in controtendenza rispetto alla regola della monocoltura, che attualmente domina un mercato che sottostima le coltivazioni dei piccoli agricoltori custodi, privi della forza necessaria per penetrare i mercati globalizzati.
Al fine di realizzare questa consapevolezza e identità giuridica del patrimonio vegetale del nostro Paese appaiono, a nostro avviso, necessari:
a) una normazione che riconosca e qualifichi la natura originaria ed autoctona delle antiche semenze e, in quanto tali, ne dia una definizione, in modo da proteggerle anche da fenomeni di “italianità” fittizia;
b) un quadro normativo d’insieme capace (oltre che di qualificare l’originalità del seme e proteggerlo) di arricchire il patrimonio culturale nazionale, inserendovi le materie prime della tradizione agroalimentare le quali, s’è detto, della cultura mediterranea sono fondamentali anelli della catena.
Una volta creata l’identità giuridica del patrimonio vegetale fondato sulla biodiversità agricola, vi è anche l’immediata necessità di predisporre un’adeguata tutela attraverso un fondamentale intervento di politica economica e culturale a tutela di quel tradizionale patrimonio genetico autoctono di interesse agrario e forestale e del connesso know-how distillato da secoli di sapiente “saper fare”: patrimonio genetico e tradizionale sapienza nel maneggiarlo, non solo da proteggere gelosamente come testimonianza di culture locali rilevanti per l’identità nazionale, ma anche da valorizzare come assets materiali e immateriali sui quali investire denaro e capitale umano per rafforzare il brand “made in Italy”.
Si tratta in definitiva di un caso tipico in cui un importante segmento del patrimonio nazionale colturale e culturale chiede immediato riconoscimento e protezione da parte del legislatore, peraltro anche in attuazione della recente modifica dell’art. 9 della Costituzione nel quale, alla tradizionale tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione, aggiunge la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi “anche nell’interesse delle future generazioni”.

3. Il paradosso della tutela normativa rivolta ai prodotti agroalimentari in assenza di protezione della materia prima (antiche sementi italiane).
Nell’immaginario di chi la guarda da oltre confine, l’Italia suggerisce l’idea del “bel Paese”, della “buona vita” in un territorio assolato e fertile, che galleggia orgogliosamente su secoli di storia ed è plasmato al centro della civiltà mediterranea, di cui l’Italia è un’irripetibile vetrina e un’insuperabile ambasciatrice. La dieta è “mediterranea”, il clima è “mediterraneo”, il paesaggio e l’ambiente sono “mediterranei”, la storia politica e artistica sono quelle “mediterranee”, in questo microcosmo mediterraneo si vive a lungo e in salute. Insomma, chi viene in Italia porta con sé l’idea di entrare in una bolla verde, luminosa ed elegante; quando alla fine ne uscirà, avrà la certezza che le cose buone sono anche belle.
Ebbene, le antiche semenze italiane sono, dunque, uno degli elementi dai quali metaforicamente fiorisce – e ogni volta rinasce – il patrimonio materiale ed immateriale su cui poggia l’identità politica, geografica, sociale e culturale del nostro Paese (quella mediterranea, appunto).
Un patrimonio ricco i cui fattori costitutivi sono tra loro legati in un complesso equilibrio: la qualità della vita mediterranea presuppone che si preservi l’ecosistema mediterraneo; la salute e la longevità dei popoli mediterranei presuppongono una affidabile qualità del cibo, trasformato secondo le corrette tradizioni gastronomiche, a partire da materie prime geneticamente “mediterranee”. Un equilibrio delicato, come si vede: basta alterare uno dei fattori e viene meno l’intero paradigma. Non c’è cultura mediterranea senza materie prime autoctone con il loro pregio varietale; non c’è dieta mediterranea senza rispetto delle tradizioni gastronomiche; non c’è qualità della vita mediterranea senza predefiniti standard ambientali e sanitari. E si ripete: senza cultura mediterranea si fa fatica a riconoscere una sicura identità nazionale.
Val la pena sul punto evidenziare che la Risoluzione del Parlamento Europeo del 12.3.2014 sul Patrimonio gastronomico europeo, ricorda che l’UNESCO ha riconosciuto la dieta Mediterranea come patrimonio culturale immateriale, “in quanto costituita da un insieme di conoscenze, competenze, pratiche, rituali e simboli correlati alle colture agricole ( …) nonché alle modalità di conservazione, trasformazione, cottura, condivisione e consumo degli alimenti” e considera la Dieta mediterranea “come una combinazione equilibrata e salutare di abitudini alimentari e stili di vita direttamente correlata alla prevenzione di malattie croniche e alla promozione della salute sia in ambito scolastico che familiare”.
Siamo sicuri che questa complessa valorizzazione della Dieta Mediterranea nelle sue importanti implicazioni sanitarie, ambientali e culturali rimarrebbe integra se alla base della catena alimentare invece di un seme “geneticamente mediterraneo” ci fosse un seme canadese o ucraino o geneticamente modificato? La domanda è retorica dato che la Dieta Mediterranea, come già detto, non è più così efficace come sembrerebbero dimostrare alcune malattie connesse all’alimentazione sviluppatesi negli ultimi 50 anni, a seguito dell’affermarsi della monocoltura. E’ quindi evidente la necessità di un apparato normativo di tutela di questo patrimonio abbandonato; apparato normativo addirittura imposto, come detto, dai principi di tutela della biodiversità, che si declina specificamente anche e soprattutto come biodiversità agricola.
Insomma, per dare stabilità ed istituzionalizzare un regime protettivo e di valorizzazione per quel patrimonio di tradizioni agroalimentari non si può prescindere dal supporto di normative nazionali ed europee, che sappiano garantire quei risultati senza vuoti di regolazione e che a tutt’oggi mancano, come di seguito si dimostra.

4. Antichi semi per nascita o per “decreto”?
Quanto alla lacuna normativa evidenziata al paragrafo 2, sub a).
Gli strateghi del marketing internazionale, i demiurghi del glamour, trainati dalla potenza del made in italy, valorizzano la consumazione prodotti alimentari derivati dalla trasformazione delle semenze italiane. Senonché, al momento, in Italia di semenze autenticamente italiane (ad esempio, i semi del grano di antica tradizione italica) ce ne sono poche e sono quelle volenterosamente curate in limitate coltivazioni da parte di contadini custodi. Il “seme italiano” venduto e consumato in Italia, infatti, per la gran parte non nasce in Italia (né tanto meno appartiene alla tradizione agricola del nostro Paese), ma è definito italiano, per effetto di una sviante dicitura normativa.
Nonostante il legislatore europeo e quello nazionale sembrano fare attenzione al concetto di Paese di “origine” e “provenienza” del seme come materia prima, in realtà, come subito si andrà a dimostrare, dettano regole fuorvianti rispetto all’obiettivo preannunciato: l’origine e la provenienza che si intendono garantire non sono concetti che collegano il seme al Paese attraverso vincoli di appartenenza geografica e storica, ma, più debolmente, affiancano il seme al Paese sul cui territorio esso viene più semplicemente coltivato o molito o confezionato.
Il legislatore, in sostanza, non valorizza l’Italian factor come elemento di intrinseca e genetica appartenenza di quel seme al nostro patrimonio agricolo, ossia la nascita, piuttosto la confonde con il dato estrinseco della semplice coltivazione in Italia di un seme, anche derivante da altre e completamente diverse culture agro alimentari, se non addirittura da manipolazioni genetiche.
A livello europeo, in materia di “informazioni sugli alimenti ai consumatori” e per la finalità di tracciamento e consapevolezza negli acquisti, si segnalano le norme che:
a) qualificano il “luogo di provenienza” come qualunque luogo da cui proviene l’alimento” (art. 2, comma 2, lett. g, Reg. UE 25.10.2011 n. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio);
b) qualificano il “paese d’origine”, come il paese o il territorio in cui le merci sono “interamente ottenute”, con la precisazione che le merci “alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione” (artt. 23 – 26, Reg. CEE n. 291/93);
c) richiedono che l’indicazione del “paese di origine” o del “luogo di provenienza” deve essere fornita in forma chiara e precisa, in modo tale da non trarre in inganno il consumatore, precisando che “quando il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario: a) è indicato anche il paese d’origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario; oppure b) il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell’alimento” (art. 7 ed art. 26, comma 3, Reg. 1169 cit.);
d) chiariscono che, a decorrere dal 1 aprile 2020, il “paese di origine” o il “luogo di provenienza” di un alimento deve essere indicato “attraverso qualunque mezzo, come diciture, illustrazioni, simboli, o termini che si riferiscano a luoghi o zone geografiche, ad eccezione dei termini geografici figuranti in denominazioni usuali o generici, quando tali termini indicano letteralmente l’origine, ma la cui interpretazione comune non è un indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza” (art. 1, 1°co., Reg. UE della Commissione n. 2018/775);
e) precisano che, relativamente all’ingrediente primario, il suo “paese d’origine” o il “luogo di provenienza” può essere diverso da quello del prodotto finito e deve essere indicato facendo riferimento ad una delle zone di provenienza: “i) UE, non UE o UE e non UE; ii) una regione o qualsiasi altra zona geografica all’interno di diversi Stati membri o di paesi terzi (…)”; oppure attraverso “una dicitura del seguente tenore «(nome dell’ingrediente primario) non proviene/non provengono da (paese d’origine o luogo di provenienza dell’alimento)» o una formulazione che possa avere lo stesso significato per il consumatore”. Dette informazioni devono essere chiare, scritte in caratteri aventi determinate dimensioni minime e devono apparire nello stesso “campo visivo” dell’indicazione sul paese d’origine o di provenienza del prodotto.
Insomma, di questa complessa normativa europea emergono gli importanti vuoti di disciplina, nella quale i concetti: “paese d’origine” e “luogo di provenienza”, provocano fraintendimenti e inammissibili equivoci per il consumatore; infatti, anziché collegarsi all’effettiva “origine” autoctona delle semenze, nate e storicamente coltivate in Italia quei concetti consentono paradossalmente di qualificare come originariamente italiano anche il seme di recente importazione ovvero addirittura geneticamente modificato, purché (soltanto) coltivato o trasformato in Italia.
La stesso vuoto di disciplina si riscontra, del resto, nella normativa nazionale, per la verità molto attenta a garantire la corretta informazione sull’origine, sulla provenienza, sulle caratteristiche del prodotto alimentare e sulla materia prima, per una scelta consapevole del consumatore, ma, paradossalmente anch’essa disallineata rispetto a quell’intento, in quanto del tutto priva di regole finalizzate a garantire l’autentica originarietà e originalità del seme nato e storicamente coltivato in Italia.
Il D.M. Agricoltura 26.7.2017 c.d. Decreto Origine, relativo alla “indicazione dell’origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro”, stabilisce infatti all’art. 2 che le confezioni di pasta secca prodotte in Italia devono avere obbligatoriamente indicate in etichetta le diciture: “a) Paese di coltivazione del grano: nome del paese nel quale il grano viene coltivato; b) Paese di molitura: nome del paese in cui il grano è macinato”. Se le suddette fasi avvengono nel territorio di più paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le diciture: “UE, non UE, UE e non UE” (art. 3, 1°co., D.M. cit.). Se il grano duro è coltivato per il 50% in un solo paese, come ad esempio l’Italia, è possibile usare la dicitura “Italia e altri Paesi Ue e/o non UE” a seconda dell’origine (art. 3, 2°co., D.M. cit.). Le indicazioni sull’origine devono essere apposte in etichetta in modo evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili.
Come si vede, anche la normativa italiana concentra la sua trasparenza informativa su criteri fuorvianti come “paese di coltivazione” e “paese di molitura”, mancando di dare alcuna nozione sull’origine, ossia la nascita, di quel grano, cosi che il consumatore che ha acquistato un prodotto etichettato come “100% grano italiano”, convinto di consumare una materia prima nata nel nostro Paese, si trova inavvertitamente nel piatto, pasta prodotta da grano importato ad esempio dal Canada, dall’Ucraina, etc.. e solo coltivato e molito in Italia; e, soltanto per questo, considerato giuridicamente italiano. In tal modo, la trasparenza diventa opacità informativa, che finisce per considerare il cibo esclusivamente sotto il profilo produttivo e industriale, non attribuendo alcun valore aggiunto, anzi trascurando del tutto l’aspetto endemico e della tradizione agricola e alimentare, che qualifica quella varietà vegetale come frazione del patrimonio della biodiversità italiana. Nè ci è di alcun aiuto la giurisprudenza, la quale si è finora limitata ad interpretare il contesto normativo esistente, senza in alcun modo formulare ipotesi innovative.
Ed infatti, chiamato a pronunciarsi sui ricorsi proposti dai produttori di pasta avverso l’obbligo di indicare il Paese di origine sulle etichette della pasta, il TAR del Lazio, con sentenza 25.1.2023, ha respinto i ricorsi sul presupposto che “(…) l’obiettivo primario del decreto (decreto Origine, 2017) sia quello di rendere al consumatore informazioni chiare e trasparenti sull’origine dei prodotti alimentari, al fine di valorizzare la sua libera e consapevole scelta, coerentemente a quanto stabilito dal Regolamento Ue 1169 del 2011″. Quindi, anche a seguito dell’intervento del TAR Lazio, il consumatore continuerà a credere di mangiare pasta da grano italiano, in quanto il Paese di origine indicato in etichetta è l’Italia, per il solo fatto che in Italia è stato coltivato o molito oppure perchè vi è la sede dello stabilimento, senza che alcuna attenzione sia invece prestata all’italianità del grano dal punto di vista della sua origine, della sua nascita.
Paradossalmente, quindi, il decreto Origine crea ancora maggior confusione nella scelta del consumatore, il quale confida ancor di più nella italianità del grano contenuto nella pasta scelta, dal momento che è specificato in etichetta che il Paese di origine del grano è l’Italia ed è ignaro del fatto che il grano è stato dichiarato italiano “per decreto”, soltanto perché, come già detto, qui è stato coltivato oppure macinato. Insomma, oltre al grano e agli altri semi forzatamente italiani “per decreto” (in base al luogo di produzione e di molitura o confezionamento del prodotto finito), occorre una normativa supplementare che consenta al consumatore di scegliere anche un grano italiano “per nascita e tradizione”, in base ad una genetica “origine” della materia prima utilizzata: solo i semi italiani hanno per nascita e tradizione caratteristiche organolettiche e nutrizionali tipiche e irripetibili del territorio italiano.
5. Non c’è cibo autenticamente made in Italy, senza semi geneticamente italiani.
Quanto alla lacuna normativa evidenziata al precedente paragrafo 2, sub b).
All’assenza di una visione normativa d’insieme, capace di valorizzare le tradizioni e la cultura italiana e, più in generale, mediterranea anche in attuazione dell’art. 9 Cost., non può venire in aiuto la disciplina che protegge e valorizza il patrimonio culturale (d.lgs. n. 42/2004, TU. Beni Culturali) la quale, sebbene espressamente finalizzata a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio ed a promuovere lo sviluppo della cultura, stabilisce che appartengono al patrimonio culturale (e quindi possano essere protette e valorizzate), tra l’altro, “le cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà” (art. 1, co 2 ed art. 2, co 2, d.lgs. cit.). Ma, attualmente, nessuna legge italiana individua gli antichi semi come elementi in grado di testimoniare un valore di civiltà, né il Codice dei beni culturali fornisce ulteriori elementi utili in tal senso. Nel nostro Paese la coltura non e’ ancora cultura!
Non può essere d’aiuto neppure la normativa sulla protezione della proprietà intellettuale, che ha ad oggetto quell’insieme di beni immateriali frutto dell’attività creativa/inventiva umana. Quanto alle “indicazioni geografiche” e alle “denominazione di origine”, infatti, la protezione riguarda esclusivamente i “prodotti” derivanti dalla trasformazione delle materie prime originarie di un paese o di un territorio, le quali di per sé non ricevono alcuna tutela (art. 29, d.lgs. 30/2005). E anche quando la tutela ha oggetto materie prime vegetali, essa si concentra esclusivamente sul diritto della “persona che ha creato o che ha scoperto e messo a punto una varietà”; insomma, il diritto è verso la “nuova varietà vegetale”, tralasciando le materie di base nate e storicamente coltivate in Italia e quindi ben conosciute nella tradizione agroalimentare e rurale del nostro Paese (art. 100 ss., d.lgs. 30/2005, T.U Proprietà industriale).
Da ultimo, si consideri che neppure viene in aiuto la recente normativa sul contrasto all’ Italian sounding (art. 32, d.l. 30.4.2019 n. 34, conv. l. n. 58/2019). Come noto, l’Italia, con il patrimonio agroalimentare – s’e’ detto – tra i più apprezzati al mondo, ha anche i prodotti più imitati; motivo per cui si è sviluppato il fenomeno dell’ italian sounding, cioè quell’insieme di pratiche fraudolente finalizzate alla falsa evocazione dell’origine italiana di prodotti, che colpisce tutte le categorie della tavola made in Italy: dai salumi ai formaggi dal vino alla pasta, dalla pizza all’aceto balsamico. Tuttavia, il legislatore, tentando di proteggere il patrimonio eno-gastronomico italiano, anche incentivando brevetti e altre forme di tutela dell’autenticità, si è concentrato esclusivamente sulla protezione dei prodotti trasformati e delle tecniche del processo di trasformazione, tralasciando del tutto di tutelare le materie prime e cioè i semi, che paradossalmente sono condizione logica e cronologica per l’autenticità di quel prodotto.
Insomma, in modo assolutamente singolare il legislatore ha tutelato il concetto di italianità a tavola, partendo dalla fine e quindi tutelando la pizza o la pasta come prodotto trasformato da materie prime, la cui origine geneticamente italiana non è in alcun modo accertata.

6. Quale possibile soluzione normativa?
Di quale tipo di normazione necessita allora questa operazione di salvaguardia degli antichi semi italiani? Sicuramente sono importantissime le iniziative di diffusione consapevole, aggregata ed impegnata di coloro che in Italia hanno interesse a recuperare quelle antiche colture e culture, creando così il sostegno necessario a quanti sono impegnati nella salvaguardia della pluricoltura e della biodiversità. Questo impegno già esiste da parte di istituzioni pubbliche e private, che attualmente vengono aggregate dal Consorzio AVASIM (attraverso il progetto M’AMA.SEEDS), che agisce come ambasciatore nella promozione e tutela delle antiche semenze autoctone italiane e dell’area del Mediterraneo, per il popolamento vegetale rispettoso della biodiversità agricola e per contrastare la diffusione di specie spesso aggressive, che si sostituiscono a quelle originarie naturalmente presenti sul territorio.
In particolare, AVASIM è un Consorzio costituito tra contadini custodi, produttori, trasformatori e distributori, che agisce per il riconoscimento della filiera agroalimentare delle antiche semenze italiane (cerealicola, orto-frutticola, vitivinicola e delle erbe aromatiche), che ha una visione unitaria multidisciplinare, volta cioè a legare le antiche semenze geneticamente e storicamente presenti nel territorio italiano non solo all’aspetto meramente agricolo, ma anche a collegare strettamente quel settore ad altri interessi primari come la tutela dell’ambiente, dell’ecosistema, della salute, della valorizzazione dei territori e delle tradizioni e che agisce altresì per far inserire gli antichi semi nell’ambito del Patrimonio culturale.
Ma per dare stabilità ed istituzionalizzare un regime protettivo e di valorizzazione per quel patrimonio di tradizioni agroalimentari, l’impegno e l’organizzazione su base volontaria è condizione necessaria, ma non sufficiente. Occorre, s’è detto, il supporto di normative nazionali ed europee, che correggendo le lacune di prospettiva sopra indicate sappiano garantire quei risultati senza vuoti di regolazione.

7. Nuove prospettive di tutela delle antiche sementi italiane, “anche nell’interesse delle future generazioni”, in attuazione dell’art. 9 Cost.
Insomma, serve un nuovo impegno legislativo europeo e/o nazionale, che colmi questa importante lacuna e protegga i nostri semi; ciò che è stato attentamente rilevato sul piano istituzionale, seppure da un profilo locale, dalla Regione Sicilia, con la lungimirante iniziativa legislativa “Born in Sicily”, concepita dal direttore generale Dario Cartabellotta e finalizzata a “favorire e promuovere la tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, forestale e zootecnico del territorio regionale, relativamente a specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni (…) che, seppure di origine esterna al territorio siciliano [devono essere] stati introdotti da almeno cinquanta anni nel territorio siciliano e risultino integrati tradizionalmente nell’agricoltura o nell’allevamento siciliano” (l.r. Sicilia, 18 novembre 2013 n. 19).
Questa iniziativa ha il merito di focalizzarsi sul problema: è necessario marcare la differenza tra varietà dei grani e degli altri semi, nati e storicamente coltivati in Italia rispetto agli altri semi di recente importazione ovvero geneticamente modificati, dandone anzitutto una specifica identità giuridica e definizione e, successivamente, una apposita e congrua normazione, che valorizzi i parametri della storicità e della territorialità, unica garanzia dell’origine italiana delle antiche varietà vegetali: un patrimonio di biodiversità da valorizzare con la costituzione della filiera degli antichi semi made in Italy, ben distinta dalle più moderne varietà vegetali non endemiche, e ciò anche e soprattutto nell’interesse delle future generazioni!